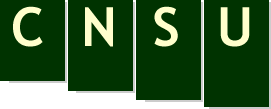18 gennaio 2011
Prot. n. 4
Spedito il 18 gennaio 2011
Roma, 18 gennaio 2011
Alla c.a. Ministro
On.le Avv. Mariastella GELMINI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
E p. c. Direttore Generale
Dott. Marco TOMASI
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
SEDE
Oggetto: la
valutazione della ricerca universitaria
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA IL SEGUENTE
DOCUMENTO
Valutare, in ambito universitario, significa stabilire criteri e
regole di giudizio sulla qualità:
- della didattica, ossia delle competenze acquisite dallo
studente e dell'offerta formativa proposta;
- della ricerca, e, dunque, dei singoli ricercatori, dei
dipartimenti ovvero dei differenti centri di ricerca;
- del sistema universitario nel suo complesso (a mero scopo
esemplificativo, si considerino i grandi ranking internazionali in
cui si classificano gli atenei, viziati però dall'uso di indicatori
profondamente disomogenei e quindi generatori di risultati
profondamente diversi tra loro).
La prima precisazione da fare è che la valutazione è uno
strumento, non un fine; essendo uno strumento tecnico, esso può
essere costruito differentemente in relazione all'oggetto della
valutazione e in base alla finalità che ci si prefigge. La scelta
degli indicatori, infatti, ha un carattere convenzionale e
consapevolmente discrezionale.
La valutazione, inoltre, può essere esterna, ed in questo caso la
sua efficacia dovrebbe essere garantita dall'indipendenza e
dall'autonomia del valutatore; ovvero interna, slegata da qualsiasi
dimensione fiscale, caratterizzata dagli interessi e dalla
competenza specifica e circoscritta di chi la compie e finalizzata
all'apprendimento organizzativo interno e al miglioramento
dell'organizzazione stessa (learning evaluation).
L'introduzione della valutazione è stata storicamente determinata
dall'esigenza di un diverso funzionamento del sistema di governo
economico e finanziario delle università, in ambito didattico e di
ricerca scientifica. A partire dal 1993, infatti, il centralismo
ministeriale nell'allocazione delle risorse tra le università e al
loro interno, inizia a lasciare spazio ad un modello decentrato,
caratterizzato dall'assegnazione di risorse a ciascuna università
secondo meccanismi di ripartizione correlati ai costi di
produzione, e dalla previsione di una quota di risorse condizionate
al raggiungimento di obiettivi specifici.
A livello nazionale, attualmente, la governance finanziaria
dell'università dispone dello strumento istituzionale del Comitato
nazionale di valutazione (Cnsvu), per il monitoraggio della
complessiva attività del sistema universitario, e del Comitato di
indirizzo per la Valutazione della ricerca (Civr). A livello
locale, poi, ogni singola università possiede un Nucleo di
valutazione per il monitoraggio e controllo dei risultati
relativamente alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione
delle risorse.
In questa prima sede di analisi, si è scelto di focalizzare
l'attenzione sulla valutazione della ricerca.
Va anzitutto sottolineato che l'ultima valutazione triennale,
fatta per il triennio 2000-2004, è stata scarsamente o per nulla
usata come valutazione degli atenei o dei dipartimenti. L'ultimo
decreto CIVR, n. 8/2010, tra le novità più significative, prevede
invece la possibilità di valutare i singoli dipartimenti (in linea
probabilmente con la richiesta di distribuzione delle risorse ai
dipartimenti e non agli atenei), di svolgere una valutazione
esplicita di un certo numero di pubblicazioni per docente anzichè
per struttura, di introdurre la valutazione ex post su reclutamento
e promozioni.
Su un livello più generale di analisi, un sistema universitario di
qualità dovrebbe avere la capacità di investire sulla libertà della
ricerca e, in particolare, dei giovani ricercatori. In questa
prospettiva, la valutazione non può che essere ex-post, rispetto
alle scelte di didattica e ricerca degli studiosi e delle strutture
accademiche. Le stesse strutture dovrebbero essere valutate non
solo sulla base della capacità di attrazione di singole eccellenze,
ma soprattutto sulla capacità di costruire capitale sociale e
culturale in cui i giovani talenti possano trovare le condizioni
per produrre innovazione e conoscenze quanto più possibili
originali.
Va poi specificato che esiste una ricerca di base, ossia astratta
e non finalizzata, ed una ricerca applicata che invece si volge a
fini od obiettivi specifici; va evidenziato anche, preliminarmente,
che non è pensabile utilizzare per i settori giuridici,
sociologici, umanistici, filosofici, storici gli stessi criteri
valutativi utilizzati per quelli scientifici. Tutte le direzioni di
studio e ricerca dovrebbero essere valorizzate da un processo di
valutazione.
Esistono due strumenti, che la maggior parte dei sistemi di
valutazione, nel settore scientifico, usa congiuntamente:
- la peer review, ovvero la valutazione tra pari, che nei paesi
anglosassoni è usata quale metodo per l'assunzione di
docenti;
- i criteri bibliometrici, fondati sull'uso di diversi indici che
tengono conto del numero di pubblicazioni dell'autore, del numero
di citazioni dell'opera e della rilevanza internazionale delle
riviste di pubblicazione, confrontandoli possibilmente con la media
degli stessi valori nel medesimo settore e nello stesso anno.
La peer review, a nostro parere, dovrebbe essere svolta
preferibilmente in forma anonima per garantirne la serietà, e da
parte di un gruppo cospicuo di studiosi (di provenienza nazionale
ed itnernazionale), in ogni caso superiori a due, per
salvaguardarne la affidabilità. Il limite di tale metodo
valutativo, in ogni caso, è indubbiamente rappresentato dal
pericolo di penalizzazione di chi fa ricerca "di nicchia" e lontana
dal mainstream.
I criteri bibliometrici, invece, hanno il vantaggio di essere più
democratici, poiché il giudizio è dato dall'intera comunità di
studiosi, e più economici, data l'automazione dei processi
bibliometrici.
Essi però, pur risultando funzionali nei settori caratterizzati da
una forte omogeneità sul piano internazionale, non possono esserlo
per molti altri settori (giuridici, sociologici, umanistici,
filosofico, storico...) in cui gli oggetti di ricerca, la lingua
usata, gli scopi prefissati non sono di interesse e comprensione
"globalizzata".
Inoltre, non esiste attualmente una banca dati bibliometrica con
un grado di copertura apprezzabile per tutte le discipline, ed in
secondo luogo vi è il rischio di ipervalorizzare singole riviste,
la cui sostanziale preponderanza potrebbe essere, financo,
determinata dall'esistenza di maggiore potere editoriale.
Con tutti i limiti del caso, questi strumenti di valutazione sono
utili se si è consapevoli del loro ineliminabile margine di errore,
della necessità che siano perfezionati e messi a punto da agenzie
realmente indipendenti e qualificate, e del fatto che i risultati
ottenuti debbano essere finalizzati al miglioramento del sistema
universitario, e non usati a mero scopo punitivo.
Un discorso specifico va fatto per le discipline
umanistiche.
Qui non è pensabile una generalizzata applicazione dei
tradizionali criteri di produttività e degli indicatori
bibliometrici, e minor importanza è attribuibile agli standard che
fanno riferimento al trasferimento tecnologico. Ciò non esclude
però l'importanza, anche in questi settori, di una maggiore
internazionalizzazione e di una seria sperimentazione di strumenti
di valutazione condivisi dalla comunità accademica.
In conclusione, affinché un sistema valutativo sia apprezzabile
positivamente, esso deve dotarsi di procedure eque e trasparenti in
rapporto sia alle riviste che alle collane editoriali, e deve
assicurarsi riguardo all'indipendenza di quanti sono impegnati
nella ricerca e nella sua valutazione. Una valutazione che sia
rigorosa, collettiva, affidabile e che sia pensata anche in chiave
di effettiva rendicontazione sociale dei risultati dell'Università
e della Ricerca.
Andrebbero in tal senso valutate anche le condizioni materiali in
cui viene fatta ricerca, e, dunque, il numero di borse di
dottorato, assegni post-dottorato e contratti di ricerca messi a
bando annualmente; le collaborazioni con le università straniere;
le infrastrutture e i sevizi posti a disposizione.
E' imprescindibile, infine, che i criteri adottati siano resi noti
in anticipo, meglio se definiti in maniera partecipata, in
collaborazione con la comunità accademica inter ed intra
disciplinarmente e che la valutazione sia di tipo ex-post, sui
risultati delle scelte di didattica e ricerca che gli studiosi
devono prendere liberamente senza condizionamenti ex-ante.
Il Presidente
Mattia Sogaro
Versione pdf del documento