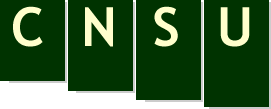|
23 dicembre 2024 Roma, 23 Dicembre 2024 Alla cortese attenzione dell'On. Ministro Sen. Anna Maria Bernini Ministero dell'Università e della Ricerca
e p.c.
Al Segretario Generale Cons. Francesca Gagliarducci Ministero dell'Università e della Ricerca segretariatogenerale@pec.mur.gov.it
Alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore dott.ssa Marcella Gargano Ministero dell'Università e della Ricerca dgistituzioni@pec.mur.gov.it
Alla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio dott. Gianluca Cerracchio Ministero dell'Università e della Ricerca dgordinamenti@pec.mur.gov.it
Alla Direzione generale della ricerca dott. Vincenzo Di Felice Ministero dell'Università e della Ricerca dgricerca@pec.mur.gov.it
LORO SEDI
CONSIDERAZIONI GENERALI:
Questo Consiglio ritiene opportuno porre alcune riflessioni concernenti il contesto interno del sistema universitario a livello nazionale in cui si inserisce la legge di bilancio per l'anno di esercizio 2025. In questo panorama, la condizione in cui verte la componente universitaria è sempre più incerta. Difatti, studentesse e studenti di tutta la penisola stanno risentendo del generale aumento dei costi della vita. Un primo aspetto da prendere in considerazione è quanto riguarda il tema del caro affitti. Una situazione che continua a peggiorare nel corso del tempo in modo drastico. Tale peggioramento trova le sue basi all'interno di una inchiesta presentata dall'agenzia immobiliare "immobiliare.it". Nel dettaglio, secondo questo report, la media del costo per l'affitto sia per una stanza singola che per una stanza doppia è cresciuta del 7%. Inoltre, un secondo dato fondamentale da prendere in considerazione è quanto riportato rispetto all'aumento della richiesta di un posto letto (a livello nazionale) del 16%. Un aumento che può supporsi essere sintomo di un mercato sempre più saturo. In aggiunta, un particolare punto di attenzione rispetto alla saturazione del medesimo è il rischio di vedere un aumento più che proporzionale dei prezzi e dei costi associati agli alloggi per gli studenti universitari. Questo consesso ritiene che la soluzione principale per evitare che la componente studentesca sia condizionato dalle logiche di un mercato così inflazionato negli ultimi anni, sarebbe quello di finanziare in maniera adeguata la costruzione o la riqualificazione di nuovi alloggi universitari seguendo quanto disposto dai target del PNRR disposti negli ultimi anni. Un'iniziativa che crediamo debba essere maggiormente valorizzata è il sostegno al pagamento del canone d'affitto, previsto dal Ministero tramite decreto MUR-MEF n. 1224, ovvero "Disciplina del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede". Questa misura di diritto allo studio dovrebbe essere resa strutturale nel tempo, non solo tramite una previsione più stabile di quella annuale, ma anche prevedendo risorse economiche sufficienti per rappresentare un reale sostegno al pagamento del canone d'affitto. A fronte degli oltre 800 mila studenti fuorisede presenti nel nostro paese, la disponibilità di posti letto negli alloggi garantiti dal Diritto allo Studio ammonta solo a 80.000 unità. Questa ampia frattura tra domanda e offerta lascia la popolazione studentesca nelle mani di un mercato viziato e oneroso come quello dei privati nel campo immobiliare. In aggiunta, come questo consesso ha già reso noto nell'ultimo commento riguardo al riparto dei fondi previsti all'interno del fondo di finanziamento ordinario (FFO), molte delle università italiane hanno subito un taglio non indifferente della liquidità disponibile per garantire un efficiente e corretto svolgimento operativo dell'intero sistema universitario nazionale come avvenuto negli anni precedenti. In particolare, possiamo notare dai primi bilanci preventivi di taluni atenei, che le università stanno presentando un'evidente difficoltà nel mantenere regolare la propria contribuzione studentesca. Una variazione che, di conseguenza, presenterà degli effetti sia sull'intera coorte studentesca che sulla qualità della ricerca e della didattica. Sarebbe dirimente una riflessione sul costo generale della formazione superiore e quindi sulla sua accessibilità economica, ma è necessario specificare che in linea generale, relativamente al sistema di tassazione negli atenei si nota una frammentazione all'interno del contesto italiano derivante dall'inesistenza di una linea guida generale e all'utilizzo di algoritmi diversi tra loro negli atenei. Il reperimento dei dati mostra tendenzialmente che il nostro Paese risulta diviso in 3 sezioni ben distinte: Nord, Centro e Sud. Infatti, sono pochi i casi in cui risulta possibile predisporre una media nazionale. Questo perché i valori sono troppo distanti tra loro e restituirebbero un dato molto diverso rispetto al 1 reale. Tale fenomeno, invece, diminuisce di gran lunga qualora si prendono si prendano in considerazione i dati delle sezioni individuate prima. Pertanto, questo consesso rileva che nel nostro paese risultano annose e sostanziali discriminazioni tra una sezione e l'altra; una situazione che, oltre a non permettere di comprendere a pieno la situazione in cui verte il nostro paese, crea discriminazioni tra chi studia al nord, al centro e al sud. Diventa cruciale sottolineare l'importanza di progetti come l'Erasmus Italiano, che promuove la mobilità degli studenti all'interno del territorio nazionale, e la necessità di incrementare le collaborazioni tra atenei del Nord e del Sud Italia. Inoltre, è fondamentale prevedere maggiori fondi per ridurre le disuguaglianze e incentivare un sistema universitario più innovativo. Questo consesso, a seguito delle numerose interlocuzioni avvenute con il Ministero e con le regioni sul tema del diritto allo studio, accoglie in maniera positiva l'aumento dei fondi previsti per il fondo integrativo statale (FIS) disposto per il prossimo anno di esercizio. Al contempo, si ritiene necessario sottolineare ed evidenziare la criticità concernente la strutturalità dei finanziamenti predisposti per l'erogazione delle borse di studio in tutta Italia e la contemporanea persistente esistenza dell'annosa figura degli studenti idonei non-beneficiari. In particolare, si evidenzia e si critica la non sufficienza di tali fondi per l'esaurimento totale della richiesta delle borse di studio da parte della compagine di studenti definita come idonei di borsa di studio. In Conclusione, si denota una stretta consequenzialità tra il costante de-finanziamento del diritto allo studio e del finanziamento del sistema universitario in generale con la posizione agli ultimi posti del nostro paese per numero di laureati. Risulta chiaro come, in un contesto così precario, senza i mezzi adeguati, studentesse e studenti italiani riscontrino innumerevoli difficoltà nell'accedere e nel portare a termine il proprio percorso accademico.
Prima di entrare nel dettaglio al commento delle singole voci previste e presenti all'interno del documento della Legge di Bilancio per l'anno di esercizio 2025, il consiglio vuole prendere in esame quanto riportato negli "obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione" da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. In particolare, si vuole fare un affondo ed analizzare questi aspetti per poter far emergere alcuni punti di interesse da parte del nostro consiglio rispetto a queste linee generali di indirizzo politico per il sistema universitario dei prossimi anni a venire. Tali priorità politiche sono suddivise, all'interno del documento della "NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO per l'anno 2025 e per il triennio 2025 - 2027", in 6 principali paragrafi: (i) Implementazione delle attività di realizzazione dei progetti PNRR di competenza del MUR; (ii) Potenziamento dell'offerta formativa; (iii) Allargamento della comunità di ricerca; (iv) Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 e programmi strategici nazionali; (v) Internazionalizzazione; (vi) Consolidamento dell'organizzazione del Ministero e sviluppo delle attività di "Policy communication".
Di questi principali indirizzi il nostro consesso vuole evidenziati quattro principali punti di interesse: 1. All'interno della seconda priorità politica il consiglio si interroga, prendendo in considerazione anche i dati contenuti all'interno delle voci di cassa e competenza del documento stesso (all'interno della tabella riportata nella missione 2, programma 2.1 "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (023.001)") , come possa essere raggiunto un completo e compiuto diritto allo studio senza una previsione pluriennale sufficiente del Fondo Integrativo Statale che possa supportare un tale fine.
2. Sempre nel medesimo indirizzo si sottolinea, come già riportato e formulato dal nostro consesso all'interno del "parere alle Linee Generali d'indirizzo della programmazione 2 triennale delle Università 2024-2026", la criticità dell'introduzione di un test standardizzato di valutazione delle competenze all'interno del panorama e dell'ecosistema universitario italiano. In particolare, si evidenzia come dal punto di vista studentesco una innovazione reale e concreta della didattica non possa partire meramente dall'utilizzo di una verifica delle competenze trasversale a livello nazionale.
3. Un ulteriore punto di interesse è quanto concerne la riforma on going del numero programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia. A questo riguardo si rimanda alla lettura di quanto disposto all'interno di una apposita mozione stilata dal nostro consiglio in data: 30 maggio 2024.
1. Fondo di Finanziamento Ordinario
Questo consesso reputa fondamentale analizzare le criticità connesse tanto all'attuale sistema di finanziamento universitario quanto alle specifiche scelte che sono state compiute per questa Legge di Bilancio, che vede nel criterio di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario un taglio nominale di 173 milioni di euro rispetto allo stanziamento previsto nella Legge di Bilancio 2024, 201 milioni rispetto al 2023. Questo dato è ancora peggiore se si guarda al fabbisogno delle università italiane, le quali hanno vissuto una diminuzione a bilancio aperto del Fondo di Finanziamento Ordinario che ha colpito 78 atenei italiani su 84, pari a circa il 93% delle università del Paese. L'ammanco totale per le università italiane - considerati anche gli adeguamenti stipendiali dei docenti - è stimato sugli 880 milioni di euro, come segnalato anche dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e senza prospettive di recupero per il 2025. La prassi, consolidatasi durante l'anno, di apportare/annunciare tagli al FFO in pieno esercizio di Bilancio rischia di non permettere agli atenei di porre in essere azioni per far crescere e progredire gli stessi. A ciò si lega la sempre maggiore tendenza a finanziare le Università attraverso fondi vincolati, frustrando così l'autonomia degli stessi. Negli ultimi 15 anni non si è stati in grado di assicurare nemmeno un recupero dell'inflazione, che dovrebbe vedere ad oggi un ulteriore stanziamento di 422 milioni di euro per permettere un'uguale capacità di spesa rispetto al 2009. Ancora, questo consesso non può che continuare a sottolineare come non vi sia alcuna previsione di riduzione progressiva della contribuzione studentesca, che si attesta in media a 930 euro annui con picchi massimi che si avvicinano ormai ai 4mila euro. L'indagine "Università, quanto mi costi" ha rilevato come siano almeno 11 gli atenei che trasgrediscono l'art. 5 del D.P.R. n.306/1997, speculando sulla comunità studentesca senza alcun tipo di conseguenza. In conclusione, sarebbe auspicabile un aumento dei fondi nel corso del prossimo triennio per raggiungere un livello di contribuzione studentesca che risulti essere accessibile per tutte e tutti, in modo tale di avere la garanzia che il sostentamento del sistema universitario si basi sui fondi erogati dallo Stato. Fondo integrativo statale Per quanto riguarda il tema delle borse di studio, questo consesso vuole esprimersi sugli stanziamenti legati al Fondo Integrativo Statale volto all'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti universitari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici. Rispetto alla previsione della Legge di Bilancio del 2025, non assistiamo a un taglio nominale di finanziamenti, ma ad un taglio reale di circa 36 milioni di euro. Questo comporterà, senza contare dell'ammontare complessivo delle risorse derivanti dal PNRR, la prossima esclusione di circa 15mila 3 studenti e studentesse dal proprio diritto alla borsa di studio per mancanza di fondi. Se ciò non fosse abbastanza grave, è da rilevare come l'aumento delle soglie di accesso ISEE ed ISPE delle borse di studio e degli importi stessi, calcolato sul valore dell'inflazione, produrrà un ampliamento della platea di idonei che però non corrisponderà ad un aumento della platea di beneficiari senza lo stanziamento di fondi idonei. Questo consesso si interroga su come sia possibile disporre aumenti dei criteri reddituali e dei benefici senza che siano predisposte le adeguate coperture economiche, più che mai necessarie. Particolarmente preoccupante è la prospettiva a medio-lungo termine: dal 2026, è previsto un repentino decremento sui finanziamenti che comporterebbe un taglio di 250 milioni di euro nel giro di un singolo anno, una riduzione di circa il 45%. Questo taglio porterebbe ad un ritorno al periodo pre-pandemico del sistema del diritto allo studio, fanalino di coda all'interno dell'Unione Europea se paragonato a quello degli altri maggiori Paesi europei. Continua ad essere critica per il Consiglio anche l'assoluta assenza di sistemi di tutela economica per la formazione post-universitaria, con particolare riferimento ai master ed ai nuovi percorsi abilitanti di formazione iniziale di 60 CFU, i quali, con i loro ingenti costi, costituiscono ad oggi un vero e proprio ulteriore freno all'ascensore sociale ed un elemento di consolidamento dello status sociale delle fasce più ricche della popolazione, senza che vengano messe in atto le previsioni costituzionali dell'art. 34. E' per questi motivi che, al fine di potenziare il diritto allo studio universitario, chiediamo che il Fondo Integrativo Statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sia incrementato di un importo pari alla somma delle borse di studio destinate agli idonei non beneficiari per il seguente anno di esercizio e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, con ulteriori adeguamenti alla stima del fabbisogno delle borse stesse. Residenzialità universitaria Relativamente alla residenzialità universitaria, nell'art 7266, si registra uno stanziamento di circa 90 milioni alla voce sul fondo edilizia universitaria che ci permette di rilevare un taglio di ca. 25 milioni rispetto a quanto stanziato nel 2024. Questi 90 milioni si inseriscono all'interno in un piano di investimento di circa 1.412 milioni sul periodo 2021- 2035 con obbiettivi: la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico attraverso programmi d'intervento di ammodernamento strutturali e tecnologici sugli immobili adibiti o da adibire all'utilizzo da parte delle università. Sono perciò da escludere da questo piano di investimento gli interventi sull'edilizia residenziale per cui sono previsti appositi fondi. Tuttavia, questi obbiettivi risultano difficilmente realizzabili. Relativamente all'edilizia universitaria, invece, possiamo denotare come rispetto al 2024 ci sia un taglio nominale di 10 milioni di euro nella legge di Bilancio 2025 nel cap. 7264. Già durante lo scorso parere i fondi risultassero insufficienti per risolvere la problematica della mancanza di alloggi negli atenei italiani. Viene poi in evidenza lo stanziamento specifico per la realizzazione e la riqualificazione degli alloggi universitari, previsto al capitolo 7273. Per quanto riguarda invece il cap. 7273, nel 2025 viene previsto un finanziamento pari a 177,352 milioni di euro il "Concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari". Si tratta di una parte delle risorse previste da un piano quadriennale da 498 milioni di euro. Tali risorse erano state assegnate, dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso appositi D.M. che hanno individuato gli immobili ammissibili di cofinanziamento statale .gli interventi ammessi al cofinanziamento statale sono 118 per un importo complessivo pari a 1.120 milioni. Un fabbisogno ben maggiore rispetto alle risorse previste per questa tipologia di intervento, che sono pari 4 a 483 milioni. Alla luce di questi dati, risulta evidente che la capienza del capitolo 7273 risulti gravemente insufficiente: atenei e gli enti pubblici hanno già accantonato milioni di euro nelle riserve per consentire gli interventi e aspettano soltanto il cofinanziamento statale per cantierare i progetti e realizzare le residenze. Il consiglio denota inoltre che i 498 milioni di euro siano sufficienti per realizzare circa 5.400 posti letto in quattro anni e che i nuovi fondi aggiungeranno al massimo altri 2.000 posti letto, numero totalmente insufficiente a fronte del quantitativo di posti letto per residenze universitaria disposto all'interno del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se questi dati dovessero confermarsi nel tempo, per esaurire le richieste degli enti regionali saranno necessari circa 10 anni. Benessere psicologico Infine, si rileva come, per quanto riguarda la salute mentale il mondo universitario, tale argomento non venga preso in oggetto d'esame in alcuna maniera dalla presente Legge. Il consiglio prende atto dell'indifferenza con cui viene valutato un argomento che lo stesso organo ha più volte cercato di portare all'attenzione del Ministero dell'Università e della ricerca, nonché del governo. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione per integrare quanto scritto sopra è il richiamo del voto favorevole di un emendamento (pari a 10 milioni di euro) attuo a finanziare il supporto psicologico nelle scuole. Una proposta che racchiude il reale intento di istituire un fondo che potesse permettere a studentesse e studenti di tutte le età di poter accedere ai giusti strumenti per poter migliorare la propria salute mentale. Pertanto, il consiglio rimane perplesso di fronte al fatto che, anche dopo alcuni fondi stanziati per il seguente tema negli scorsi anni, la salute mentale della componente universitaria non sia stata presa minimamente in considerazione. Istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) Sul sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è previsto un taglio di 12 milioni di euro sui fondi complessivi, con una riduzione del 28% sul supporto alla programmazione, del 30% su interventi di edilizia e attrezzature e del 22 % per il miglioramento dell'offerta formativa. Nella necessità di garantire il funzionamento degli istituti AFAM si richiede almeno il ripristino delle risorse stanziate nel 2024, con un conseguente incremento dei fondi destinati alla programmazione, alle strutture e al diritto allo studio.
Medici Specializzandi Per quanto concerne le misure in merito al miglioramento della condizione dei medici in formazione specialistica e degli specializzandi non medici, il CNSU riconosce il desiderio di questo governo di adeguarsi, seppur gradualmente, a standard europei di retribuzione ed abolizione di incompatibilità con attività libero professionali, fermo restando che le misure attuate in questo contesto sono ancora insufficienti a garantire una adeguata dignità retributiva e professionale a queste categorie.
Misure a sostegno del sistema della ricerca (dottorato, post-doc, carriera universitaria) La Legge di Bilancio 2025 lascia trasparire una persistente e sostanziale mancanza di interventi mirati al potenziamento delle borse di dottorato e al sostegno al sistema di ricerca universitaria. Nonostante l'art. 1, commi 639 e 640, l. 205/2017 avesse stabilito un adeguamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca a partire dal 2018, con incrementi successivamente formalizzati dal D.M. 40 del 25 gennaio 2018 e dal D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022, il cui ultimo aggiornamento ha portato 5 l'importo lordo annuo a €16.243,00, tale livello di finanziamento appare ancora inadeguato per rispondere alle attuali esigenze di sostegno alla comunità dottorale in Italia. Diversi studi hanno messo in luce l'insufficienza delle borse di dottorato rispetto al costo della vita, un problema acuito dall'inflazione e dal confronto con gli standard europei. Tale disparità rappresenta un grave ostacolo all'attrattività dei corsi di dottorato italiani, non solo per i laureati italiani, ma anche per quelli stranieri, con conseguenze negative sulla competitività internazionale del sistema accademico italiano. Un ulteriore elemento critico è rappresentato dall'aumento del minimale contributivo INPS, che impedirà ai dottorandi di accumulare un'annualità contributiva completa. Tale dinamica, oltre a incidere negativamente sulla sostenibilità finanziaria personale dei dottorandi, mina le prospettive previdenziali future di una categoria già svantaggiata. Si stima che per adeguare le borse di dottorato a un importo netto di €1.280 mensili, sarebbe necessario un investimento di €158 milioni per il 2024 e di €60 milioni a decorrere dal 2025. La Nota Integrativa non prevede altresì alcun intervento specifico per supportare il personale tecnico-amministrativo impegnato nella gestione delle dotazioni del PNRR in ambito dottorale e post-dottorale. Tale lacuna rischia di compromettere la capacità delle università di sfruttare efficacemente i fondi disponibili, aggravando ulteriormente le difficoltà operative delle strutture accademiche. Parallelamente, manca qualsiasi riferimento a finanziamenti per i contratti di ricerca istituiti dalla riforma dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come da ultimo novellata, così come a stanziamenti utili per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (RTT), viste altresì le misure adottate nel corso dell'anno scorso che hanno de facto sterilizzato l'impiego delle risorse ovvero della dotazione di punti organico dei piani straordinari, come rilevato dal Parere CUN del 24 luglio 2024. In un contesto in cui il sistema accademico soffre di un cronico definanziamento, l'assenza di piani per il riassorbimento di ricercatori formati nell'ambito del PNRR costituisce un'ulteriore manifestazione di scarsa lungimiranza strategica. Un aspetto che merita attenzione rispetto alla Nota Integrativa alla Legge di Bilancio è il ruolo attribuito al Fondo Italiano per la Scienza (FIS). Tale strumento rappresenta un'importante risorsa per il finanziamento di progetti di eccellenza, modellato sull'European Research Council (ERC). Tuttavia, l'entità dei fondi stanziati appare ancora insufficiente - e, anzi, in riduzione rispetto all'attuale dotazione - per affrontare le sfide del sistema accademico italiano, specialmente se si considera il confronto con i budget disponibili a livello europeo. I fondi del FIS necessitano di essere allocati seguendo criteri di trasparenza e perequazione territoriale, privilegiando allo stesso tempo e con maggiore incisività il sostegno per i giovani ricercatori. Inoltre, l'utilizzo del FIS dovrebbe essere ampliato per includere finanziamenti destinati a promuovere sinergie tra ricerca fondamentale e applicata, senza trascurare la necessità di supportare i giovani ricercatori attraverso specifici bandi mirati. Solo un rafforzamento del FIS, sia in termini finanziari che strategici, potrebbe garantire un impatto significativo nel lungo termine. Il quadro delineato nella Legge di Bilancio riguardante i Programmi di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) per il triennio 2025-2027 non evidenzia una strategia stabile e coerente per il consolidamento della ricerca fondamentale. Si prevede di finanziare un numero costante di 5.350 progetti per il 2025 su fondi PNRR, senza un ulteriore finanziamento per il 2026 e il 2027. 6 Il finanziamento dei PRIN ha rappresentato un elemento chiave all'interno delle priorità strategiche del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 e ha trovato un ulteriore impulso dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Legge di Bilancio. L'enfasi posta dalla Legge di Bilancio sulle infrastrutture di ricerca e sull'espansione dei dottorati industriali, pur rappresentando un passo positivo, non riesce a rispondere alle esigenze strutturali di integrazione e sostenibilità del sistema accademico. Il linguaggio politico-gestionale utilizzato, come l'espressione «capacità imprenditoriale del sistema della ricerca», sembra ulteriormente marginalizzare il valore della ricerca di base e fondamentale, orientando l'azione degli atenei verso logiche puramente economiche.
Per affrontare efficacemente queste problematiche, si suggeriscono i seguenti interventi: 1. Incremento delle borse di dottorato, con l'obiettivo di raggiungere un importo netto di €1.280 mensili, adeguando le condizioni economiche dei dottorandi agli standard europei. 2. Stanziamenti dedicati al personale tecnico-amministrativo, per garantire la piena efficienza nella gestione delle risorse PNRR. 3. Rafforzamento delle posizioni da RTT e da contrattista di ricerca, per garantire il rientro dei ricercatori formati in Italia e la retention degli early-career researcher in Italia. 4. Riconoscimento e valorizzazione della ricerca fondamentale, superando una visione eccessivamente imprenditoriale e promuovendo un approccio più inclusivo e interdisciplinare, avvalendosi del rifinanziamento dei PRIN e del FIS. Tali misure sono indispensabili per invertire la tendenza al definanziamento e rafforzare il ruolo strategico dell'università e della ricerca nel futuro del Paese.
In conclusione, l'intero consiglio esprime un parere negativo rispetto alla formulazione del bilancio previsionale dello Stato per l'anno di esercizio 2025.
La presidente
Versione pdf del documento |
Motore di ricercaMenu SecondarioLink utiliMUR |